Critica musicale contro storia della musica
In musica, il tempo è fondamentale. Se c’è una cosa fondamentale, senza la quale la musica non esiste, è il ritmo, e il ritmo altro non è che tempo scandito.
Dico spesso che ogni essere umano appartiene al proprio tempo e nessuno, con buona pace delle palestre, dei centri benessere e delle creme anti-age, può fare finta di essere nato ieri. Da ragazzo ho amato svisceratamente i Beach Boys, gli Stones, i Beatles, Ray Charles e Jimi Hendrix; oggi mi piacciono i Kasabian, i Temples, e certe ringhiose band appena nate, ma questo non mi sposta nel futuro, forse solo in un passato appena più recente e meno cavernoso. Credo che tenere d’occhio l’evoluzione delle cose aiuti, e molto (Ivano Fossati) (1).
Ogni persona ha un suo tempo, e ogni tempo ha una sua musica. Ricordo con nostalgia adesso mio papà che strimpellava al pianoforte cose antidiluviane, e mi chiedevo come facessero una volta ad ascoltare quella roba. In quanto a me, ero già “vecchio” a quattordici anni: mentre i miei coetanei si gasavano con punk, new wave e il primo heavy metal (che a quei tempi non era ancora stato retroattivamente retrodatato ai primi anni Settanta), io avevo “ereditato” i gusti di mio fratello che ascoltava Atom heart mother (che è stato per me un vero “imprinting”) e In a white shade of pale, e Smash Hits di Jimi Hendrix, di mia sorella che mi fece comprare The dark side of the moon, e delle figlie del mio vicino, più grandi di me, patite dei Genesis. Un altro disco che mi capitò facilmente di ascoltare al tempo, e che influenzò per sempre i miei gusti, fu Made in Japan dei Deep Purple. Stranamente, la musica che avrebbe dovuto essere “mia” la recuperai molto più tardi: dopo averli odiati per anni e anni scoprii che i Bee Gees disco erano molto divertenti, così come i gruppi a cavallo tra hard rock e heavy metal come i Motorhead o i Judas Priest, per non parlare dei Black Sabbath. Così trovai anche divertente l’ondata punk di Sex Pistols, Clash e Dead Kennedys, certe frange del pop anni Ottanta e il grunge di Nirvana e Pearl Jam.
Lì mi sono fermato, e la musica degli adolescenti di oggi mi è estranea, anche se non ho difficoltà a capirla. La capisco perché le generazioni in fondo sono musicalmente divise tra “pre-Beatles” e “post-Beatles”. Per mio padre Jimi Hendrix era cacofonia pura; ricordo un’intervista ad Andres Segovia dove il grande maestro manifestava puro orrore per la chitarra elettrica, e ricordo pure quel prete espertissimo di musica classica che disse, alla sagra della parrocchia provando ad ascoltare il “complessino” dei gruppi giovanili, «questa non è musica, è fracasso». I gusti musicali sono in fondo un retaggio storico e culturale, culturale nel senso antropologico del termine.
Non me la sentirei perciò mai di parlare di ciò che è successo dopo la morte di Kurt Cobain, che conclude tragicamente la parabola del movimento “grunge” ossia dell’ultima variante di rock per il quale io abbia manifestato un certo interesse. Il mio universo musicale si è fermato a metà anni Novanta, e le eccezioni sono pochissime, guarda caso gente che si richiama esplicitamente alla musica che fu come Amy Winehouse o i Tame Impala.
Ho un rapporto, diciamo così molto bonariamente, di amore-odio nei confronti dei c.d. critici musicali. Internet ha banalizzato moltissimo le recensioni che già lasciavano molto a desiderare ai tempi dei periodici “giovanili”. Molti sembrano scrivere tanto per scrivere, evidentemente sottopagati a tot a parola, e sembrano cercare di coprire la mancanza di spessore dovuta allo sfruttamento dei copywriter cercando troppo spesso la sparata ad effetto. I critici musicali poi sembrano essere inguaribili feticisti delle sinestesie (ad esempio “liquido paesaggio sonoro”, “rapide pennellate delle tastiere”, “chiaroscuro armonico”, ecc.), che saranno anche molto poetiche ma non sostanziano affatto il discorso. Inevitabile quindi la caduta nell’aneddotica o comunque nel banale. Alla fine devono pur scrivere per vivere facendo finta di sapere qualcosa di quello che stanno scrivendo.
Non dico che non esistano anche critici musicali seri, anzi, ma è proprio qui che ho le maggiori difficoltà. Il critico musicale serio ha per (de)formazione mentale l’abitudine di guardare le cose da un punto di vista sincronico, di “guida all’ascolto”, prendendo i prodotti musicali dei vari autori e considerandoli come una cosa a sé, avulsa da qualsiasi considerazione che non sia quella dell’analisi tecnica. Io invece sono portato a guardare le cose da un punto di vista diacronico, calato nel contesto spazio-temporale della vita degli autori e del loro ambiente. Si tratta in fondo di una riproposizione del vecchio dibattito filosofico tra storicismo e strutturalismo.
Inoltre non comprendo e non approvo la mannaia dei giudizi critici (appunto) sui vari prodotti musicali, con lo spreco di aggettivi tipo “sopravvalutato”, “sottovalutato”, “mediocre”, “capolavoro” o quant’altro. Ognuno di noi ha le sue infatuazioni e le sue idiosincrasie, e alla fine per quanto possa essere raffinato il giudizio è sempre soggettivo. Io per esempio amo Atom heart mother e invece Animals mi annoia (perché trovo che le idee musicali da cui trae origine, pur eccellenti, non erano abbastanza per coprire un intero LP e perciò trovo i tre brani di Animals troppo “tirati” e quindi prolissi). Ma ho conosciuto o sentito un’infinità di fans dei Pink Floyd per cui è l’esatto contrario. Chi ha ragione? Tutti e nessuno.
Non amo affatto perciò le stroncature e le “scaruffate” dei critici di professione fatte passare per dati oggettivi. I giudizi critici sullo stesso identico prodotto musicale sono, da parte di questi critici peraltro musicalmente preparati, talmente divergenti da far pensare che, per quanto si sia capaci di disquisire su progressioni di settima di dominante in sei ottavi con tritono e supercazzola con scappellamento a destra, alla fine la vera cartina di tornasole rimane sempre e comunque se il prodotto musicale piace o meno al critico in questione, e il gusto musicale ha sempre una sua componente irrazionale e imponderabile. Potrei portare decine di esempi di critici “professionisti” che sullo stesso disco hanno riportato giudizi diametralmente opposti, segno che non esiste un qualcosa di “oggettivo” al quale la professionalità del critico possa attingere.
Soprattutto, il gusto è strettamente legato alla formazione musicale del critico: caso emblematico quel critico rock – peraltro tutt’altro che sprovveduto – di estrazione rigidamente classica che stroncava sistematicamente tutti i prodotti musicali di sapore jazzistico perché colpevoli di mancanza di “qualità tematica” e di “concezione strutturale”, secondo la classicissima equivalenza improvvisazione=disordine (2). Alla fine, per quanto esposti in modo teoreticamente raffinato, anche per i gusti dei critici vale l’universalmente nota massima latina.

Il “rock”, come tutta la musica popolare, ha un carattere eminentemente commerciale che non ha mai perso nemmeno nei suoi momenti creativi più felici. Quella discografica è un’industria che produce musica (per questo ho usato il termine “prodotto musicale”) da vendere in un mercato, e come qualsiasi attività produttiva e commerciale è tesa soprattutto a massimizzare i profitti piuttosto che a promuovere l’espressione artistica. La dialettica tra pubblico, musicisti e case discografiche è, secondo chi scrive, la vera essenza del discorso, molto più che il brano o l’album in sé nelle sue relazioni strutturali interne. La casa discografica può costringere un musicista a sfornare un prodotto banale perché la gente non è più abituata ad ascoltare musica, ma d’altra parte la gente non è più abituata ad ascoltare musica perché trova in giro solo proposte discografiche banali.
Antinomie idealtipiche
Croce e delizia della critica rock sono i generi musicali. Ho assistito a interminabili battibecchi sui social se un dato gruppo “è prog” o “non è prog”. L’esempio del “prog” e della diatriba “hard rock o heavy metal” sono emblematici di come voler vedere le cose solo dal lato strutturalista-sincronico perché più “professionale” porti a delle antinomie epistemologiche non indifferenti. Oltretutto, molte “etichette di genere” sono invenzioni delle case discografiche per commercializzare i loro prodotti. Robert Burns (3) scrive che il termine “folk-rock” fu coniato dalla Island Records per descrivere la musica di uno dei suoi gruppi, i Fairport Convention.
Il termine “progressive” appare per la prima volta, sembra (4), nelle note del primo LP omonimo dei Caravan, quindi addirittura precedentemente al primo disco dei King Crimson. Il suo uso diffuso però, almeno nell’esperienza di chi scrive, si è generalizzato molto più tardi. Quando noi invece usiamo il termine “pop”, intendiamo sostanzialmente la corrente mainstream della musica popolare, quella più “commerciale” ed “easy listening”. Così definiamo i Genesis di Nursery Cryme “progressive” e quelli di Abacab “pop”.
Quando chi scrive iniziò ad ascoltare musica, a cavallo tra gli anni Settanta e gli Ottanta, il termine “progressive” non era per nulla utilizzato e i dischi dei vari King Crimson, Van Der Graaf Generator, Gentle Giant ecc. gli sono stati presentati come “rock barocco”. Altri termini che giravano erano quelli di “rock sinfonico”, “art rock”, “rock classico”. Tutti epiteti peraltro assolutamente inadeguati e perciò anch’io, nonostante non ami affatto questo nome, mi sono rassegnato a chiamarlo “rock progressivo” (5).
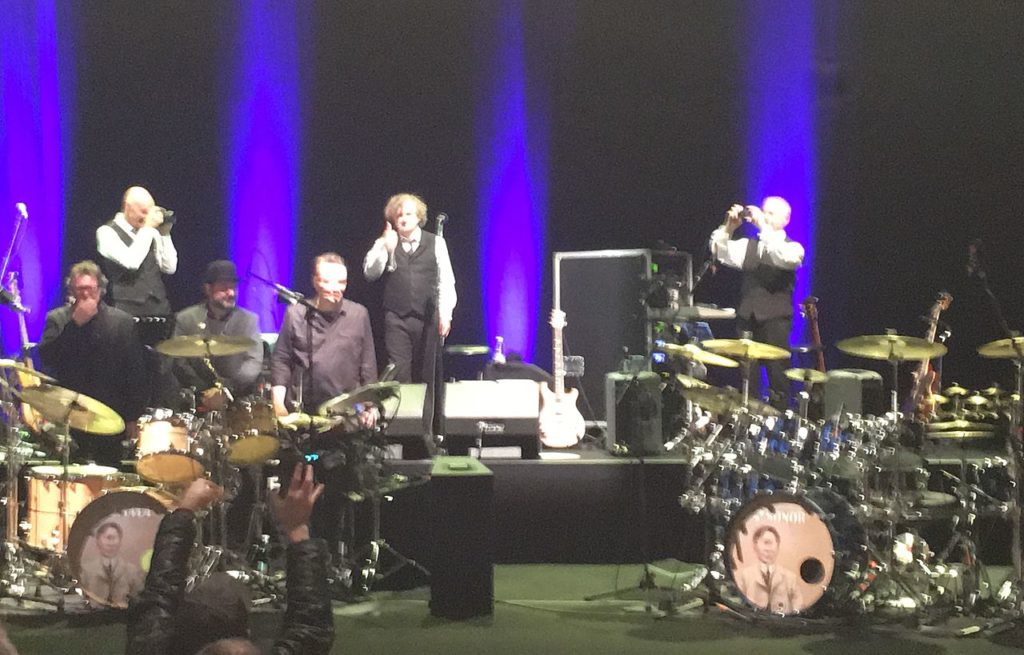
A questo punto la domanda sorge spontanea: «cos’è che definisce il perimetro stilistico ed estetico del progressive?» (6). Qui non bisogna cedere alla tentazione della classificazione linneana delle specie attraverso i caratteri morfologici che è la delizia dei critici professionisti “strutturalisti”. Il “genere musicale” è un concetto troppo evanescente per cercare di incasellarlo secondo criteri standardizzati, secondo la prassi di creare un “idealtipo” simil-weberiano e poi confrontare i vari lavori musicali se corrispondono o meno a questo.
L’esempio più calzante di quanto sto dicendo è il “Canterbury Sound”, o meglio la “Canterbury Scene”, che annovera musicisti e gruppi dallo stile diversissimo come i Soft Machine dei primi tre LP, i Caravan, gli Hatfield and the North, i Camel, Steve Hillage, gli Egg, per non parlare dei Gong; e, secondo un’interpretazione diciamo molto estesa (7), anche gli olandesi Supersister e gli italiani Picchio dal Pozzo. Cercare un minimo comune denominatore struttural-stilistico che vada oltre una vaga similitudine nel suono delle tastiere è impresa vana. Questo perché il concetto di “Canterbury” è un concetto storico più che stilistico: si riferisce a un gruppo di musicisti che hanno intessuto tra di loro fitte relazioni personali prima e professionali poi, relazioni che però da un punto di vista stilistico hanno creato nelle loro composizioni tutt’al più una certa qual “aria di famiglia” se così si può dire, rarefatta quanto indefinibile. Anche perché i musicisti “canterburiani”, prima di rassegnarsi all’amarcord, hanno sempre portato avanti tutti una buona dose di sperimentazione di nuove formule sonore.
I generi musicali
Un genere musicale è una categoria convenzionale che identifica e classifica i brani e le composizioni in base a criteri “idealtipici” di affinità (8). L’idealtipo fornito dall’analisi formale e stilistica, anche se molto “professionale” perché chiaramente può essere fatta bene solo da addetti ai lavori e non da semplici ascoltatori appassionati, non è però l’unica risorsa euristica per definire un genere, anzi come ho cercato di spiegare prima, se estremizzata può essere addirittura fuorviante. Altri parametri per definire un genere sono la tradizione musicale (nulla è generato dal nulla), l’ambiente di sviluppo (ad esempio i locali “underground” londinesi di fine anni Sessanta), e anche il pubblico di destinazione. L’indeterminatezza di alcuni di questi parametri rende spesso la divisione della musica in generi, o peggio ancora in sottogeneri, controversa e arbitraria.
Alla fine, la catalogazione in generi non deve essere vista come una metafisica linneana, ma come uno strumento di comodo per portare un minimo di ordine nella trattazione. Scannarsi sulla questione se i Pink Floyd “sono prog” o “non sono prog” non porta da nessuna parte. E poi è anche una questione mal posta, poiché un autore o un “complesso” hanno una loro storia stilistica che a seconda dell’evolversi dell’ambiente (9) e delle pressioni dei discografici, più che della libera ricerca musicale, porta ad esiti anche molto differenti tra loro. I Pink Floyd di Ummagumma non sono i Pink Floyd di The Dark Side of the Moon, che non sono i Pink Floyd di The Wall e men che meno quelli di The Division Bell.
Secondo il musicologo britannico Philip Tagg, esisterebbe nella musica una “tricotomia” basilare “tradizionale-colta-popular”.
Con il termine musica colta ci si riferisce principalmente alle musiche di tradizione classica, includendo in questo genere forme musicali sia della musica contemporanea che di quella classica storicizzata. In Occidente la musica colta è caratterizzata dalla tradizione musicale scritta, preservata da forme di notazione musicale.
La musica tradizionale o folclorica è definita dalla trasmissione orale, ovvero viene tramandata attraverso il canto, l’ascolto e talvolta la danza. Essa deriva inoltre da particolari tradizioni, regioni e culture essendone parte integrante.
Con il termine popular music ci si riferisce a tutti quei generi musicali accessibili ad un pubblico generalista e largamente divulgati dai mass media. La popular music si può trovare nelle stazioni radio più commerciali, nei rivenditori più popolari, nei centri commerciali, nelle colonne sonore televisive e di molti film. I brani vengono spesso inseriti in classifiche di vendita, e oltre al cantante, all’autore o al compositore, coinvolge il ruolo del produttore musicale, molto più di quanto non facciano gli altri due macrogeneri. Il musicologo britannico Philip Tagg, studioso della popular music, ha definito la nozione alla luce di aspetti socio-culturali ed economici:
«La popular music, diversamente dalla musica colta è 1) concepita per la distribuzione di massa rivolta a gruppi di ascoltatori ampi e spesso socio-culturalmente eterogenei 2) vendibile e distribuibile in forme non scritte 3) esclusivamente possibile in una economia monetaria industriale dove si trasforma in una merce, e 4) nelle società capitaliste, soggette alla legge della libera impresa… in quanto deve essere idealmente il più possibile vendibile» (10).
A mio parere questa tricotomia non tiene conto dello status particolare del Jazz che da musica leggera si è evoluto nel secondo dopoguerra in una vera e propria musica “colta”. Prova ne è che ha subito un processo di “storicizzazione” simile a quello della musica classica. Sarei quindi propenso ad accettare questa tripartizione, piuttosto naturale, a patto di sostituire “popular” con “musica moderna”, all’interno della quale distinguere tra Jazz e “musica popolare” (11), con quest’ultima poi suddivisa nei vari generi universalmente conosciuti. Oltretutto, il Jazz è sempre stato visto come qualcosa di profondamente “altro” rispetto al rock e al pop.
Vincenzo Caporaletti introduce (parlo per fonte secondaria) (12) il concetto di “medium formativo”, «ovvero l’interfaccia (ambiente cognitivo) con la quale l’autore forma l’opera». Il concetto di ambiente cognitivo è molto interessante, perché spiega bene ad esempio la “forma mentis” del critico musicale classicista di cui ho detto prima. Le musiche si distinguerebbero in musiche di tradizione scritta classica-europea (per cui un musicista classico in genere non suona se non accompagnato dal suo bello spartito), musiche di tradizione orale (in modo molto banale, basta pensare alle differenze anche sostanziali con cui vengono suonate le stesse canzoni di chiesa da parrocchia a parrocchia), e musiche “audiotattili”, termine sofisticato e per me un po’ inutile con il quale definire la musica che, come il Jazz, lascia larghi spazi all’improvvisazione e dove perciò il pezzo non viene fissato su uno spartito, ma su una registrazione (si pensi agli assoli rock per chitarra: l’assolo “canonico” per Highway Star e Smoke on the Water è quello di Made in Japan e qualsiasi variazione sul tema lascia il sapore di qualcosa di riuscito poco bene).
In un simile contesto l’analisi formale del brano non è l’unico criterio per definire un genere musicale: esso deve venire visto anche attraverso le lenti della propria epoca storica (il Jazz degli anni Trenta non è il Jazz degli anni Sessanta), della propria collocazione geografica (ad esempio il progressive inglese importato in Francia, Italia e Germania ha dato origine a specifiche varianti locali), della strumentazione usata (ad esempio organo Hammond e mellotron danno subito un’idea di progressive inizio anni Settanta), e dell’ambiente/funzione sociale (il R&R come derivato per i bianchi del R&B nero, oppure le musiche di Natale o per i matrimoni, ecc.) (13).
Arriviamo adesso a doverci addentrare in un vero e proprio campo minato, ovvero cercare di separare e definire i vari generi che compongono la “musica popolare”. Secondo Wikipedia, «il termine popular music nacque negli anni venti ed era usato in senso molto ampio per riferirsi all’intero corpus della musica occidentale di massa, intesa come “di gradimento generale, diffuso” (“having popular appeal”)» (14). È evidente che questa definizione, che trova un suo corrispettivo in Italia nella vecchia e oggi desueta nozione di “musica leggera”, non è affatto applicabile alla categoria “musica popolare”. Di fatto, è molto più facile dire quello che la musica popolare non è che quello che è, e questo ci porta di fatto a inserire nella “musica popolare” tutto ciò che non è musica classica-colta, non è Jazz, e non è musica folklorica tradizionale. In pratica un enorme calderone dove va a finire tutto, dal R&R e R&B al Country&Western, dal Rock al Progressive, all’Heavy Metal fino al Rap/Hip-Hop e alla musica da discoteca.
Per tentare di andare oltre bisogna certamente abbandonare la categoria mentale di “genere” come rigido idealtipo stilistico, per parlare meglio di “correnti storiche”: la musica R&R/R&B degli anni Cinquanta, la stagione Hard Rock e Progressive degli anni Settanta, la Disco-Music degli anni Ottanta, il Punk e la New Wave dello stesso periodo, tutta la galassia dell’Heavy Metal, eccetera.
Un esempio preclaro di come i generi musicali si ridefiniscano col tempo sono i Black Sabbath, negli anni Settanta definiti tranquillamente “hard rock” come Led Zeppelin e Deep Purple e oggi invece considerati il primo gruppo “compiutamente metal” sulla base di considerazioni musicologico-strutturaliste, mentre storicamente non si può parlare di heavy metal come genere a sé prima della “New Wave of British Heavy Metal” (NWOBHM) di fine anni Settanta. Prima di questa data in Italia non si parlava di “heavy metal” e in Gran Bretagna il termine era semplicemente un sinonimo di hard rock. I Judas Priest prima maniera poi sono considerati “heavy metal” solo perché si chiamano Judas Priest: il loro primo disco, “Rocka Rolla”, di metal non ha niente e in alcuni passaggi ricorda i Queen. Solo a partire da “Stained Class” del 1978 i JP iniziano ad assumere un sound più “metallico” per poi evolversi in chiaro senso metal con “British Steel” e “Screaming for Vengeance”, cioè guarda caso proprio quando storicamente l’heavy metal come genere a sé si stava definendo. La tendenza a retrodatare la nascita dell’heavy metal arrivando perfino alla fine degli anni Sessanta sembra la ricerca del blasone in un albero genealogico.

E il “pop”? Anche qui, come per la “musica popolare”, è più facile dire cosa il pop non è che cosa è. La popular music non va confusa con la pop music (o musica pop), espressione che, pur condividendone le radici (infatti pop vale come contrazione di popular), viene «ormai acquisita come parola identificativa di un non ben identificabile sottoinsieme della musica popular, più facile e commerciale di altri», connotato da «uno stile di sicura presa sul pubblico e di facile consumo», che è divenuta fenomeno di consumo di massa a partire dagli anni cinquanta del Novecento (15).
Il “pop” inteso come musica “commerciale”, e qui calza a pennello il vecchio concetto di “musica leggera”, ha avuto una profonda evoluzione storica che lo ha reso camaleontico dal punto di vista stilistico, anche perché onnivoro nei confronti della musica popolare più “impegnata”. Negli anni Cinquanta, in America “musica leggera” erano il R&R, il R&B e i gruppi Country&Western, in Europa i vari cantanti che si ricollegavano all’inizio alla musica jazz più orecchiabile oppure alle varie tradizioni locali (in Italia per esempio la canzone napoletana oppure gli stornelli romani). Negli anni Sessanta i Beatles e i Rolling Stones erano considerati “musica leggera” in contrapposizione alla musica classica e al Jazz; oggi fanno parte della tradizione più blasonata del rock.
Esistevano poi le orchestre o i musicisti che oltre a brani propri eseguivano arrangiamenti di brani famosi, come quelle di Bert Kaempfert o di Frank Pourcel, il duo Santo & Johnny o il sassofonista nostrano Fausto Papetti che rielaborava brani famosi altrui e le cui cassette, dalle copertine diciamo molto seducenti, si trovavano in tutti gli autogrill. Questo tipo di musica può essere considerata il c.d. “easy listening” vero e proprio degli anni Sessanta e Settanta.
Ai primi anni Settanta, quando per un breve periodo felice una discreta fetta di pubblico, non la maggioranza però, si abituò ad una musica più raffinata, il “pop” era costituito da gruppi e “cantautori” (categoria dominante nell’Italia anni Settanta) che semplificavano il linguaggio del rock più blasonato in modo da renderlo più facilmente fruibile (sono gli anni in cui spopolarono Simon & Garfunkel, Neil Young e altri). Negli anni Ottanta abbiamo il pop di Madonna, di Michael Jackson e di Prince, il filone pop chiamiamolo “post-progressive” dei vecchi mostri sacri riciclati come Yes, Genesis, Phil Collins, Peter Gabriel, dove il nome richiedeva un minimo di ricercatezza formale magari semplificando il linguaggio progressive precedente, la musica da discoteca che stava perdendo le proprie origini soul-funk per abbracciare l’elettronica. Attualmente abbiamo i derivati commerciali del Rap/Hip-Hop e un’invasione di disco simil-latina.
Oggi dopo il fenomeno delle reunion di due decenni fa la gran parte dei protagonisti o è defunta o non è più in grado di suonare in pubblico, e perciò di questi gruppi rimangono le registrazioni, soprattutto audio. È sulle registrazioni che oggi si basano i tentativi di “storicizzare” le frange artisticamente più significative della musica “popolare”. I video possono ad esempio testimoniare le coreografie dei concerti live, tipo le luci dei Pink Floyd, che tentavano di coinvolgere nello spettacolo anche la vista dello spettatore. Ai tempi molta parte aveva anche la teatralità dei musicisti rock, associata anche al loro tentativo di legarsi alla “controcultura” e ai movimenti “giovanili”, ma oggi questo aspetto ha perso grandemente di importanza, soprattutto perché è oggi chiaro il suo intento puramente commerciale. Non è un caso che nella critica musicale più avvertita l’anedottica sia largamente scomparsa.
Note
(1) IVANO FOSSATI, I giorni della musica, Prefazione a ENZO GENTILE, Time after time. Dove, quando e perché nella storia del pop-rock, Milano, Hoepli 2016.
(2) Non dico il nome di questo critico, autore diversi anni fa di un Dizionario della musica rock. Nonostante moltissime riflessioni assolutamente intelligenti, egli nell’analizzare i vari dischi si lasciava andare a stroncature tagliate con l’accetta che facevano chiedere se avesse veramente ascoltato quelli e non altri.
(3) ROBERT G.H. BURNS, Experiencing Progressive Rock. A Listener’s Companion, London, Rowman & Littlefield. Rob Burns è stato tra l’altro uno dei bassisti dei miei adorati Nucleus < https://en.wikipedia.org/wiki/Rob_Burns >. Mi scuso per i riferimenti bibliografici tutt’altro che raffinati.
(4) < https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_rock >.
(5) Sarebbe interessante se qualcuno, dotato delle capacità e del tempo necessari, scrivesse una storia della critica rock, affrontando in particolare l’evoluzione storica della definizione dei vari generi e sottogeneri.
(6) < https://www.ondarock.it/speciali/progressive.htm >.
(7) < https://www.progarchives.com/subgenre.asp?style=12 >.
(8) < https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000040599 >. L’associazione mentale tra “genere musicale” e “idealtipo weberiano” è evidentemente talmente ovvia che ci ero arrivato da solo prima di leggere questa pagina web. Sto rielaborando liberamente < https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_musicale >.
(9) E’ da tenere sempre presente che i cosiddetti “gusti del pubblico” non sono una variabile indipendente, perché soprattutto dagli anni Ottanta in poi si muovono all’interno dell’orizzonte dato dalle proposte delle case discografiche.
(10) PHILIP TAGG, Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice, in Popular Music, vol. 2, Cambridge University Press, 1982, p. 41-42. La citazione, di seconda mano, è presa da < https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_musicale >.
(11) Secondo Wikipedia, «La necessità di riferirsi a un concetto ingombrante come popular music in termini comprensibili e comuni a tutti, ha generato un dibattito ancora aperto e una serie di espressioni, spesso usati erroneamente come sinonimi da studiosi e appassionati: musica leggera, commerciale, di massa, rock, pop. Una tale proliferazione di termini nasce probabilmente dall’esigenza di rendere al meglio nella lingua italiana la traduzione inglese di popular music. Sebbene si possano riscontrare casi in cui si è deciso di tradurre letteralmente dall’inglese popular music all’italiano musica popolare, molti studiosi accusano il termine “musica popolare” di creare confusione. In molti quindi preferiscono l’uso del termine “popular music” applicato alla lingua italiana» (< https://it.wikipedia.org/wiki/Popular_music >). Io personalmente non trovo tutta questa ambiguità nella traduzione “musica popolare”, una volta che questa sia distinta dalla “musica tradizionale”.
(12) VINCENZO CAPORALETTI, I processi improvvisativi nella musica, Lucca, LIM, 2005.
(13) Rielaborazione da it.Wikipedia.
(14) < https://it.wikipedia.org/wiki/Popular_music >.
(15) ibid.






